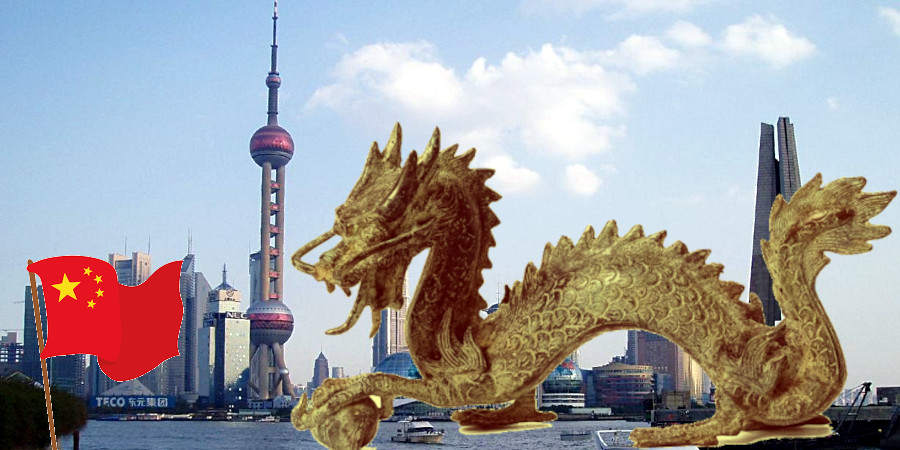Vladimiro Giacché (Relazione al I° Forum promosso dalla Rete dei Comunisti – Roma 13-14 Maggio 2006)
1. Che fine ha fatto la “fine della storia”?
Da quando esiste il capitalismo, la grande illusione del nesso tra libero scambio, prosperità e pace, si è periodicamente riproposta. In qualche caso, l’illusione di un libero mercato portatore di pace è giunta a riscuotere un consenso pressoché generalizzato all’interno delle società capitalistiche. Così è avvenuto negli anni successivi alla caduta del muro di Berlino e all’implosione del blocco sovietico. Il successo editoriale che arrise in quegli anni ad un’opera mediocre quale La fine della storia e l’ultimo uomo, di Francis Fukuyama, per quanto pilotato politicamente (l’opera è del 1992, e dal 1990 il suo autore era a capo negli USA dell’ufficio del Dipartimento dì Stato per la pianificazione politica), si spiega con il fatto che quel libro incontrava realmente lo “spirito dei tempo”. Anche per questo è istruttivo rileggerne ora le tesi principali.
Per Fukuyama “lo sviluppo della democrazia liberale e del suo compagno, il liberalismo economico, è stato il fenomeno macropolitico più notevole degli ultimi quattrocento anni” [1] In questo contesto “il carattere mondiale dell’attuale rivoluzione liberale assume una rilevanza tutta particolare. Esso costituisce infatti un’ulteriore prova che è in atto un processo fondamentale che detta un comune modello evolutivo per tutte le società umane, qualcosa come una storia universale dell’umanità che si muove in direzione della democrazia liberale”. Col prossimo trionfo planetario delle “democrazie liberali”, anche grazie alla “creazione di una cultura universale dei consumi basata sui principi liberali”, si avrà la “fine della storia”, quantomeno della “Storia intesa come processo evolutivo unico e coerente”.
E si tratta di un processo ormai assai avanzato: già adesso, per Fukuyama, la guerra è priva di senso. Non serve a procacciarsi materie prime come il petrolio: “dato che l’accesso a queste risorse si può ottenere pacificamente attraverso un sistema globale di libero scambio, la guerra ha economicamente molto meno senso che non due o tre secoli addietro”. Anche la fine del nazionalismo “è ormai segnata”, e “nessun barbaro è alle porte”. Infine, “un mondo fatto di democrazie liberali” ha “incentivi alla guerra assai ridotti” (come dimostrerebbe il fatto che “negli ultimi duecento anni le democrazie liberali non si sono comportate imperialisticamente tra di loro”). [2] Conclusione: non solo l’unità dell’occidente è salda e garantita una volta per tutte, ma siamo ormai prossimi alla “pace perpetua”.
È interessante notare che, nei primi anni Novanta, anche molti di coloro che contestavano l’idea che il “nuovo Ordine” emerso dalla fine della guerra fredda avrebbe dischiuso una prospettiva di pace, abbracciavano invece l’idea dell’unitarietà e compattezza dell’occidente. Asor Rosa, ad esempio, riflettendo sulla prima guerra all’Irak, vedeva nell’occidente un “blocco compatto”, un “blocco unitario, resistentissimo”: al punto da applicare ad esso il concetto di “imperium”; e ancora nel 1999, nel pieno della guerra del Kosovo, vedeva in questo “Occidente” monolitico il “destino dell’uomo” [3].
Rileggere queste pagine, a distanza in fondo di poco più di un decennio da quando furono scritte, fa un certo effetto. Era tutto sbagliato. Il “trionfo delle democrazie liberali e del libero mercato” non ci ha portato la pace e la stabilità, ma nuove guerre. E in una sequenza che negli ultimi anni si è fatta frenetica: Kosovo (1999), Afghanistan (2001) Irak (2003). I bookmakers di Londra accettano già scommesse sulle prossime guerre (Iran, Siria, Corea del Nord, Cuba…?), e a questo argomento ha dedicato un articolo sul New Yorker il grande giornalista americano Seymour Hersch [4] Nazionalismi e conflitti a sfondo (o pretesto) etnico imperversano, in Europa e altrove. Di guerre per le risorse ne abbiamo avute due nel giro di due anni (Afghanistan e Irak).
Quanto all’unità dell’occidente, è sufficiente andarsi a rileggere il dibattito all’Onu sulla seconda guerra all’Irak, o anche soltanto le opinioni espresse pubblicamente da consiglieri del presidente Usa, per avere un’idea chiara della situazione: l’occidente, inteso come unità (economica, politica ed ideologica), è semplicemente andato in pezzi. Più in particolare, i rapporti tra Stati Uniti ed Europa sono tesi come mai lo erano stati dal 1945 ad oggi – e, a dispetto di riavvicinamenti diplomatici di facciata, sono destinati a peggiorare ulteriormente. Lo stesso tentativo di ricostruire un’unità fittizia sulla base della “comune guerra contro il Tenore” (cioè contro i “nuovi barbari”…), dello “scontro di civiltà”, dell’ “esportazione della democrazia”, appare pretestuoso e di corto respiro.
2. Dopo il 1989… il 1914?
Insomma: tutto sbagliato. Ovviamente, però, se le previsioni di Fukuyama si rivelano sbagliate oggi, è perché le sue teorie erano sbagliate ieri. Già allora qualcuno faceva notare che l’ordine bipolare della guerra fredda aveva ceduto il passo ad un’era di “disordine”e “violenza”.[5] È facile sottoscrivere oggi questa opinione. E non solo dal punto di vista politico: gli anni Novanta sono stati tra i più turbolenti e instabili del dopoguerra sotto il profilo economico. Le crisi finanziarie si sono susseguite ad un ritmo impressionante (Messico, Asia, Russia, Argentina, Turchia, ma va ricordato anche lo scoppio della bolla speculativa della “new economi)”).
È ben difficile considerare tutto ciò come la tranquilla stabilizzazione di un sistema vittorioso. La “fine del comuniSmo”, insomma, tutto può apparire fuorché l’inizio di un’era di pace e di prosperità. Ma forse si può dire di più: proprio il periodo successivo al crollo del blocco socialista dell’Est europeo, se analizzato senza i paraocchi, ci conferma la validità di un’analisi marxista della realtà economica attuale. A questo riguardo la Rete dei Comunisti nel corso degli ultimi anni ha prodotto elaborazioni significative, a cui rinvio [6]. Anche alla luce della disponibilità di queste elaborazioni posso limitarmi, in questa sede, ad un cenno agli elementi che ritengo essenziali all’interno dell’attuale dinamica di sviluppo.
La crescita mondiale negli anni Novanta è stata mediamente inferiore a quella dei decenni precedenti [7]. E alla caduta del saggio di profitto che in tal modo si è verificata il capitale ha reagito in diversi modi. Questi modi corrispondono in gran parte a quelli riportati da Marx tra le “cause antagonistiche” alla caduta tendenziale del saggio di profitto [8]. Vediamoli in sintesi:
1. Aumento del grado di sfruttamento del lavoro.
“Il grado di sfruttamento del lavoro e l’appropriazione dei pluslavoro e del plusvalore – scriveva Marx – vengono soprattutto accresciuti mediante il prolungamento della giornata lavorativa e l’intensificazione del lavoro stesso”. Nel periodo considerato questa contromisura è stata posta in essere tanto nei paesi in via di sviluppo, in cui si sono delocalizzati impianti industriali, quanto nei paesi a capitalismo avanzato. Se le forme del lavoro salariato cambiano, non cambiano le dinamiche dello sfruttamento. Da questo punto di vista è assolutamente emblematico l’aumento dell’orario di lavoro a parità di salario (cioè l’aumento del plusvalore assoluto) realizzato nelle aziende private di un paese quale la Germania. Contemporaneamente sono andati avanti i processi di precarizzazione della forza-lavoro e l’attacco alle varie componenti del salario indiretto e differito (aumento dei servizi pubblici, generalizzata diminuzione della protezione sociale, privatizzazione dei sistemi pensionistici pubblici). L’altra faccia della medaglia è ovviamente la crisi della domanda interna, oggi riscontrabile in molti paesi europei. Ma attenzione: oggi, grazie alla struttura delle multinazionali (che hanno la testa nei paesi imperialistici, le fabbriche nei paesi “emergenti”), è perfettamente possibile che le multinazionali facciano profitti brillanti, mentre la disoccupazione nel Paese in cui hanno la sede principale cresce e le condizioni di lavoro (e quindi anche la domanda interna) peggiorano; questo è di fatto quello che è accaduto – negli Usa, ma in parte anche in Europa – negli ultimi anni. Questo fenomeno accentua la polarizzazione di classe entro le stesse società a capitalismo maturo: si pensi al cosiddetto “declino della classe media” (che non significa altro dal marxiano “impoverimento crescente della classe operaia), alla crescente presenza di working poors, ma anche all’aumento della distanza tra le retribuzioni dei dipendenti di livello più basso e quelle dei grandi manager (che sono a tutti gli effetti “capitalisti operanti”).
2. Diminuzione di prezzo degli elementi del capitale costante.
Questa contromisura è stata resa possibile – oltreché dal progresso tecnologico – dallo spostamento della produzione di semilavorati e subforniture in paesi con un basso costo della forza-lavoro (ossia con un alto tasso di sfruttamento della forza-lavoro) ed anche, sino al 2001, da un prezzo molto basso di gran parte delle materie prime, non soltanto energetiche. Quest’ultimo fattore è oggi venuto meno.
3. La sovrappopolazione relativa.
Questo aspetto gioca un ruolo importante tanto nei paesi della periferia quanto in quelli del centro imperialistico. Per quanto riguarda questi ultimi, oggi interessati da importanti flussi migratori, è interessante osservare ad esempio che il tanto decantato ruolo dei servizi nel creare occupazione negli Stati Uniti dei tardi anni Novanta va ricondotto in massima parte ad occupazione a bassi salari e bassa produttività del lavoro, resa possibile dalla disponibilità di molta manodopera in eccedenza [9].
4. Il commercio estero.
Secondo Marx questo fattore rappresenta una “causa antagonistica” rispetto alla caduta del saggio di profitto per vari motivi. In primo luogo, il volume della produzione si accresce consentendo un ampliamento di scala della produzione e quindi una riduzione dei costi unitari di produzione. In secondo luogo, la superiorità tecnologica delle merci prodotte in un determinato paese può consentire un sovrapprofitto nel fare concorrenza a merci prodotte altrove con tecnologia meno avanzata e quindi a prezzi superiori. Ma per converso, in terzo luogo, determinate produzioni ad inferiore contenuto tecnologico possono, come abbiamo visto sopra, essere delocalizzate verso paesi con un costo della manodopera più basso e quindi garantire un saggio di profitto superiore rispetto all’investimento effettuato. Dagli anni Novanta ad oggi lo sviluppo del commercio estero e la creazione di un mercato mondiale (che è poi ciò che si intende quando si parla di “globalizzazione”) ha consentito di frenare la caduta del saggio di profitto in tutti e tre questi modi. Per quanto riguarda i paesi a capitalismo maturo (o – come diceva Lenin – “più che maturo”), è interessante notare che il secondo dei tre fattori, che per un lungo periodo era stato quello più importante (dando origine a molte teorizzazioni sullo “scambio ineguale” come elemento permanente del dominio dei paesi imperialistici sui paesi dominati), ha perso relativamente peso, grazie agli impressionanti progressi tecnologici compiuti da paesi quali India, Cina e altri stati del sud-est asiatico. Va però sottolineata un’altra peculiarità della situazione attuale: l’ampliamento del commercio oggi deve essere inteso in senso non soltanto geografico, ma qualitativo. In altri termini, esso va nel senso di ampliamento della sfera del commercio, ossia di ciò che è commerciabile e viene messo a profitto. Tra le contromisure alla caduta del saggio di profitto vi è infatti la messa a profitto dei beni comuni (a cominciare dall’acqua) e l’ampliamento di ciò che è coperto da brevetto (e qui si va ormai dal genoma alla proprietà intellettuale). Di fatto, il capitale in crisi di valorizzazione reagisce colonizzando ogni ambito dell’esistenza.
Tornando al commercio estero in senso stretto, va notato che per Marx esso soltanto nel breve periodo può essere considerato una “causa antagonistica” alla caduta del saggio di profitto: infatti “lo stesso commercio estero, sviluppando all’interno il modo capitalistico di produzione e con ciò provocando la diminuzione del capitale variabile rispetto al costante, e dando luogo d’altro lato ad una sovrapproduzione in rapporto alla domanda estera, produce a sua volta alla lunga l’effetto opposto” [10].
5. L’accrescimento del capitale azionario.
Quest’ultimo fattore, cui Marx si limita ad accennare, è riferito al ricorso del capitalista a capitali altrui, il cui costo è inferiore a quello di capitali direttamente impiegati nell’impresa o presi a prestito dalle banche (rendendo quindi proporzionalmente più elevato il rendimento che il capitalista riesce ad ottenere sul capitale proprio). Anche questo aspetto è risultato molto importante negli anni Novanta, se pensiamo allo sviluppo dell’azionariato di massa ed alla creazione della bolla speculativa alla fine del decennio.
Sin qui per quanto riguarda le tendenze antagonistiche alla caduta tendenziale del saggio di profitto: le quali secondo Marx fanno sì che essa sia appunto nulla più che una tendenza che esercita i propri effetti nel lungo periodo. Nulla più, ma anche nulla meno: la diminuzione del saggio di profitto è una tendenza reale ed in nessun modo esorcizzabile. Quali sono i suoi effetti? Uno su tutti: “la diminuzione del saggio di profitto accelera, a sua volta, la concentrazione di capitale e la sua centralizzazione mediante l’espropriazione di piccoli capitalisti, degli ultimi produttori diretti sopravvissuti, presso i quali vi è ancora qualcosa da espropriare” [11].
Anche il processo di concentrazione dei capitali ha fatto progressi da gigante nel corso degli anni Novanta. Basti pensare che nel 2000 il valore delle fusioni tra imprese a livello mondiale aveva raggiunto i 5.000 miliardi di dollari, un valore pari a 10 volte quello delle fusioni transnazionali nel 1990. L’ondata di fusioni, temporaneamente rallentata in seguito allo scopo della bolla speculativa del 2000, ha conosciuto una vigorosa ripresa negli ultimi anni. Il processo di concentrazione del capitale ha creato dei veri e propri colossi monopolistici (a New York hanno creato anche un indice apposta per loro: i “Global Titans”). Per avere un’idea delle dimensioni di imprese del genere basti pensare alla multinazionale petrolifera Usa Exxon Mobil: nel 2005 questa società ha realizzato 36 miliardi di dollari di profitti, pari al PIL di 125 stati messi assieme. La concentrazione è così avanzata che in certi casi siamo di fronte a situazioni di quasi-monopolio da parte di una singola impresa: si è ad esempio calcolato che oltre 1’80% dei computer del mondo giri sui sistemi operativi della Microsoft.
Come è noto, gli sviluppi della teoria marxista che vengono rubricati sotto la voce (un po’ imprecisa) di “teorie deH’imperialismo”, e che ebbero la loro fioritura nei primi due decenni del Novecento, videro proprio nel processo di concentrazione uno dei caratteri fondamentali della nuova fase del capitalismo [12]. Ma anche altri aspetti, pure sottolineati da queste teorie, quali raffermarsi del “capitale finanziario” (da intendersi come “la fusione del capitale bancario col capitale industriale” e non – come vorrebbe una frettolosa vulgata – come “finanziarizzazione” contrapposta all’”economia reale”) e la crescente importanza acquisita dall’esportazione di capitale in confronto con l’esportazione di merci, trovano eclatanti conferme nelle tendenze attuali [13]. A quest’ultimo riguardo va però registrata un’importante differenza rispetto ai primi anni del Novecento: oggi sono maggiori i flussi di capitale che dalle periferie si dirigono verso il centro imperialista di quelli che intraprendono il percorso contrario (anche se gli investimenti diretti esteri provenienti da Usa, Unione Europea e Giappone diretti in Cina e India sono stati negli ultimi anni decisamente imponenti). Questo aspetto è molto importante, e aiuta a spiegare la centralità che assume oggi la dimensione valutaria nel confronto tra i diversi poli imperialistici. Oggi la forma fenomenica assunta dalla lotta per il controllo delle aree di influenza tra le principali potenze capitalistiche è quella della lotta per l’ampliamento delle aree valutarie. Precisamente a questa lotta gli anni successivi alla fine dell’unione Sovietica hanno strappato il velo. Il fronte d’attacco è il predominio valutario del dollaro.
Perché attacco al dollaro e perché proprio adesso? Ecco la risposta che ha offerto a questo riguardo un economista liberal Usa:
“Per decenni, il mondo occidentale ha tollerato (“esorbitante privilegio’ [14] di un’economia fondata sul dollaro come riserva mondiale perché gli Stati Uniti rappresentavano la potenza necessaria per garantire… una sicurezza affidabile contro il comuniSmo e la rivolta sociale, così da creare le condizioni nelle quali molti paesi da questa parte della cortina di ferro hanno potuto crescere e prosperare. Queste motivazioni sono svanite 15 anni fa… Così, quello che un tempo era una transazione effettuata a malincuore con il paese egemone – che rappresentava pur sempre l’elemento di stabilizzazione del mondo – è ora visto, in cerehie molto ampie, come la continua sovvenzione ad uno stato predatore” [15].
È proprio la fine dell’URSS, insomma, a far saltare gli equilibri. A vedere le cose da questo angolo visuale, la successione degli avvenimenti è impressionante. Nel febbraio del 1991, con la prima guerra irachena, il Golfo Persico diventa un “lago americano” (Huntington). L’Urss finisce nell’agosto 1991. Nel febbraio 1992, dopo mesi di negoziati, viene firmato il trattato di Maastricht, che pone le basi per la moneta unica europea. Nello stesso anno 1992 una tempesta valutaria – che colpisce severamente la lira italiana e la sterlina inglese – sembra sul punto di far saltare tutto. Ma il progetto dell’euro non si ferma. Guido Carli – che fu tra i negoziatori italiani del trattato – nelle sue memorie, scritte nel 1993, ne motiva la necessità con parole molto dure nei confronti degli Stati Uniti: “Gli Stati Uniti hanno esercitato lungamente un diritto di ‘signoraggio’ monetario verso il resto del mondo… La realizzazione del trattato di Maastricht significherebbe la sottrazione agli Stati Uniti di quasi metà del potere di signoraggio monetario di cui dispongono… L’Unione economica e monetaria prefigura la nascita di uno strumento monetario di riserva internazionale che potenzialmente può cancellare molto del potere di attrazione che oggi ancora il dollaro riveste, per assenza di valide alternative. Conquistare potere di signoraggio significa anche acquisire la capacità di attirare capitali, di spostare risorse, di partecipare da posizioni di forza alla distribuzione mondiale del lavoro e del capitale”[16].
Dietro le guerre che hanno insanguinato il mondo dagli anni Novanta ad oggi c’è anche questo. Sino alla guerra irachena, emblematica per l’ampio spettro dei suoi obiettivi: è una guerra per le risorse (smentendo clamorosamente Fukujama), ma anche per la difesa dello status di valuta intemazionale di riserva del dollaro (oggi garantito principalmente dal pagamento in dollari del petrolio), e per l’alimentazione del gigantesco complesso militare-industriale Usa.
Le dinamiche a cui stiamo assistendo sono schiettamente imperialistiche. In particolare, le politiche condotte in questi ultimi anni dagli Usa (ma non soltanto da loro: vedi Kosovo) dimostrano almeno tre cose: 1) che la crisi c’è, e si vede; 2) che, a dispetto del mantra liberistico del “meno stato, più mercato”, oggi come ieri (ed anzi più di ieri) lo stato interviene pesantemente a sostegno dei settori trainanti del grande capitale (nel caso specifico i grandi monopoli dell’energia e della difesa) [17]; 3) che, tra gli strumenti a cui si fa ricorso, non c’è più soltanto il protezionismo (come nel caso della battaglia protezionistica sull’acciaio lanciata durante il primo mandato di Bush), ma anche la guerra.
È facile osservare che, dietro il comodo paravento della cosiddetta “guerra al terrore”, sono caduti uno dopo l’altro tutti i tabù che avevano circoscritto e delimitato i conflitti bellici durante i decenni del confronto tra Usa e URSS: ivi incluso il tabù dell’uso dell’arma nucleare. Da questo punto di vista, pochi esempi sono rivelatori dei mutamenti avvenuti negli ultimi anni più quanto il passaggio dalla speranzosa affermazione del 1989 secondo cui “le guerre maggiori” (“major wars”) sarebbe ormai scomparse dall’orizzonte dell’umanità ai documenti strategici americani del 2001 in cui leggiamo che gli Usa devono porsi “in grado di combattere allo stesso tempo due guerre maggiori (major theatre wars)”[18]
Nel frattempo, il mondo appare sempre meno sotto controllo dei “soliti noti”.
Interi blocchi di Paesi, a cominciare dall’America Latina, stanno imboccando strade di sviluppo autonomo e oggettivamente antagonistico tanto rispetto al dominio esercitato dagli Usa quanto rispetto ai diktat delle multinazionali (siano esse basate in Usa o nell’I/nzone Europea). E la cosa da notare è che allo stato attuale appare impraticabile tanto la soluzione militare del problema, quanto quella finanziaria: a questo proposito va notato che i paesi dell’America Latina appaiono oggi molto meno vulnerabili di un tempo al rialzo dei tassi di interesse Usa (al punto che qualche settimana fa, in concomitanza con l’ultimo rialzo dei tassi americani, alcuni di essi hanno abbassato i propri tassi d’interesse). Si tratta di una circostanza di cui tenere conto: perché significa tra l’altro che il giochetto di esportare crisi finanziarie in periferia per importare capitali nel centro imperialista, riuscito alla perfezione più volte negli anni Novanta, oggi mostra la corda.
Stanno emergendo nuove grandi realtà economico-politiche, come la Cina, (‘India, lo stesso Brasile. Per quanto riguarda in particolare l’Asia, sembra concretizzarsi progressivamente la possibilità che lo yuan cinese divenga la valuta dell’area.
La stessa Russia intende tornare a giocare un ruolo da protagonista sulla scena internazionale, a partire dal terreno energetico (due dati significativi recenti: Gazprom è oggi la terza società del mondo per capitalizzazione di borsa, dietro Exxon e General Electrics; la Russia ha raggiunto il 4° posto a livello mondiale per entità delle riserve in oro e in valuta). I paesi del Caucaso stanno cominciando a rispedire a casa gli Usa e le loro basi, e sembra consolidarsi un asse Russia-Cina-India.
Altro che “fine della storia”, del suo sviluppo e delle sue contraddizioni!
3. Un altro mondo è impossibile?
Per dirla in modo chiaro: le contraddizioni della società capitalistica a cui Lenin diede la sua risposta con la rivoluzione d’Ottobre sono ancora tutte lì. Ci sono la caduta del saggio di profitto, le crisi da sovrapproduzione e c’è la realtà dello sfruttamento. C’è il protezionismo e c’è la guerra. E c’è in più la distruzione dell’ambiente, che è già sul punto di divenire irreversibile. Questa conclusione è obbligata per chiunque intenda stare ai fatti, mettendo in fila e dando un senso logico agli avvenimenti degli ultimi anni.
Su tutt’altro piano si muove il beato mondo dell’ideologia dominante. Ma attenzione: questa ideologia è largamente passata nelle coscienze. Sotto questo profilo si avverte tuttora (e direi sempre di più) l’onda della sconfitta.
Credo che si possa affermare che è precisamente su questo piano, ideologico e politico assieme, che si collocano le conseguenze più di lungo periodo del crollo dell’unione Sovietica e dei Paesi dell’Est europeo. Che possono essere così sintetizzate:
1. Perdita di credibilità di un’alternativa di sistema al capitalismo.
Assistiamo al trionfo dell’ideologia e della filosofia della storia liberali: per cui il capitalismo (che oggi si preferisce chiamare eufemisticamente “economia di mercato”) [19] è il punto di approdo della storia. E al suo coté “riformistico”: per cui quello che non va nella società capitalistica è di natura contingente e non strutturale. Detto in altri termini: se il “mercato”, la “libera concorrenza” potessero liberamente dispiegare i propri effetti, vivremmo tutti nella società perfetta. Allo Stato si potrà al massimo assegnare il compito di correggere le “inefficienze del mercato” [20] e, al limite (ma questo viene detto sempre più timidamente), operare blande politiche redistributive, o “di solidarietà” nei confronti dei “deboli”, degli “umili”, degli “ultimi” (gli pseudonimi più in voga per “sfruttati”). Secondo altre impostazioni – invero più coerenti – questo compito andrà invece attribuito alla carità privata. È importante rilevare che gli stessi movimenti di critica della “globalizzazione” condividono in buona parte con l’ideologia dominante la radicale sfiducia nella possibilità di un’alternativa di sistema al capitalismo. La qual cosa è facilmente rintracciabile nel fortunatissimo slogan “Un altro mondo è possibile”: slogan che nega se stesso già attraverso la propria indeterminatezza; e al quale non a caso fanno seguito proposte che si guardano bene dal mettere in discussione i rapporti di proprietà.
2. Esorcizzazione di ogni tentativo di costruire una società socialista, riconducendo la storia del “socialismo reale” al concetto di “totalitarismo”.
Alcune delle pagine più vergognose di questa riscrittura della storia sono state scritte nel nostro Paese (si veda l’equiparazione tra fascisti e partigiani comunisti; e si veda anche il caso delle foibe, da un lato assimilate ai campi di sterminio, dall’altro considerate “dimenticando” che violenze su scala molto più ampia erano state compiute nella guerra di aggressione condotta dall’Italia fascista sul territorio jugoslavo). Più in generale, si è affermata una concezione della storia del Novecento in cui l’orizzonte di pace determinato dalle cosiddette “democrazie liberali” è turbato dai due “totalitarismi”, comunista e nazista [21]. Questo stravolgimento della storia è oggi funzionale da un lato a fare scomparire dall’orizzonte visuale la violenza intrinseca al dominio economico del capitale (in tutte le sue manifestazioni), dall’altro a esorcizzare e bandire come “totalitario”, “antidemocratico”, “liberticida”, ecc. ogni tentativo di porre in discussione la radice di questo dominio: ossia la proprietà privata dei mezzi di produzione.
3. Rifiuto della centralità – e ormai dell’esistenza stessa – del conflitto di classe.
La realtà dello sfruttamento scompare nelle raffigurazioni ideologiche contemporanee. Scompaiono le classi, la co scienza di classe, la lotta di classe (attualmente nella Repubblica Ceca è in corso il tentativo di mettere fuori legge l’organizzazione giovanile del Partito Comunista perché nel suo statuto è presente il concetto di “lotta di classe’’…). Questo avviene proprio mentre numericamente la classe dei salariati su scala planetaria (con la distruzione progressiva delle comunità rurali) raggiunge vette mai toccate prima, mentre la coscienza di classe della classe dominante è più salda che mai, e mentre la lotta di classe dall’alto da essa condotta inanella vittorie importanti (ho già citato l’aumento dell’orario di lavoro a parità di salario in Germania: pervenire alle cose di casa nostra, si possono ricordare la precarietà di massa nel nostro Paese, i 6 milioni di lavoratori al nero e la politica fiscale regressiva e classista). Trionfa invece l’ideologia dei “diritti”, che del giusnaturalismo classico eredita l’astoricità e l’astrattezza e ad esse aggiunge l’irrilevanza pratica. E mentre si fa un gran parlare (in parte senz’altro giustamente) dei cosiddetti “diritti delle minoranze”, continuiamo ad attendere invano che qualcuno ci parli dei “diritti della maggioranza”, ossia dei lavoratori salariati, e magari – facendo un passo in avanti – ce ne parli spiegandoci che non esistono “Diritti” che si possano rivendicare in astratto, ma soltanto “bisogni” che solo attraverso le lotte possono venire riconosciuti quali “diritti” (e che – per questo stesso motivo – in assenza di lotte vengono inesorabilmente perduti).
4. Il consumatore contro il produttore.
La scomparsa, fin nel lessico, del lavoratore, è un fatto. Per contro, sempre maggiore preminenza viene invece data, nel discorso politico ed economico contemporaneo, alle forme fenomeniche del “consumatore” e del “risparmiatore”. Per fortuna ogni tanto qualcuno timidamente osserva che “lavoratore” e “consumatore” in genere coincidono in una stessa persona (come del resto in molti casi anche “lavoratore” e “risparmiatore”) [22]. La centralità ideologica del “consumatore” (con tutto il suo bagaglio di “razionalità”, “diritti” e addirittura “sovranità”), altro non è se non lo specchio di un rifiuto della dimensione della produzione quale elemento centrale (anche di ogni ipotesi di trasformazione sociale) – a favore dei momenti della distribuzione e del consumo. Questo per un verso è espressione della sovrapproduzione endemica di merci in determinati settori, ma rappresenta soprattutto una formidabile arma di distrazione di massa dalla realtà oggettiva del conflitto di classe.
5. Costruzione di microidentità fittizie e tribalizzazione dei conflitti.
Tra le conseguenze della scomparsa dall’orizzonte visuale della realtà delle classi e dello sfruttamento, vi è la costruzione di identità e microidentità fittizie e comunque surrogate, che svolgono una duplice ed importantissima funzione ai fini del mantenimento dell’attuale assetto sociale: quella di distrarre le classi subalterne dalla necessità dell’organizzazione di classe, e all’occorrenza quella di rappresentare un comodo alibi per la repressione. Sul piano intemazionale, in particolare, questo si traduce nella tribalizzazione dei conflitti, che avviene incanalando la protesta sociale sui falsi binari dell’”identità” etnica e dell’appartenenza religiosa. Cosicché le energie disponibili vengono disperse su obiettivi sbagliati/fìttizi e la repressione militare può trovare un più facile consenso. Come è stato osservato, la “politica dell’identità” ha segnato negli ultimi 15 anni importanti successi, e questo nonostante che “la maggior parte delle identità, soprattutto quelle che si definiscono ‘etniche’, abbia radici storiche poco profonde che spesso sono state ricostruite solo di recente”; perché “l’identità è come Dio: anche se non esiste, è comunque estremamente potente, tanto che c’è chi è disposto ad uccidere in suo nome’’ [23].
6. Declino della democrazia formale.
Il restringersi dell’orizzonte di possibilità provocato dall’eliminazione di quell”’altro mondo realmente possibile” che era rappresentato dalle “società socialiste” ha precise e gravi conseguenze sullo stato di salute della democrazia nel mondo. Questo è vero già anche soltanto da un punto di vista formale. Il “mercato elettorale” (comica espressione, che purtroppo in genere viene pronunciata con grande serietà) è senz’altro quello più angusto dal punto di vista dell’offerta. Si assiste infatti al curioso paradosso per cui, se il centro capitalista è sempre più chiaramente l’incarnazione dell’ “immane raccolta di merci” di marxiana memoria, il “cittadino-consumatore” che vi abita si trova a dover scegliere in rebus politicis prodotti sempre più insapori e uguali tra loro. Al punto che ormai Io stesso principio dell’alternanza (comunque tra compatibili) è venuto meno e ha lasciato il posto direttamente ad un’alleanza-. così è avvenuto in Germania, dove possiamo assistere ad una Grosse Koalition che vede governare assieme SPD e CDU-CSU. La cosa ha una sua logica, dal momento che i rispettivi programmi elettorali si distinguevano per sfumature e poco più. Ma ha un significato che travalica il caso specifico ed assume una valenza più generale (che prossimamente, venuta meno l’anomalia Berlusconi, potrà interessare da vicino anche l’Italia): il fatto è che se ogni orizzonte di cambiamento sociale è escluso a priori dall’ambito del possibile e del praticabile, la politica non potrà poi consistere che nel garantire le migliori cornici amministrative al dispiegarsi del dominio del capitale.
7. Perdita della “memoria di classe”.
Identità, coscienza e memoria sono strettamente legate tra loro. La perdita dell’identità e della coscienza di classe significa anche la perdita della “memoria di classe” [24]; e viceversa: smarrire il filo rosso della storia delle lotte comporta un vulnus gravissimo alla possibilità stessa di costruire un’identità e una coscienza di classe oggi. È fuori di dubbio che a partire dagli anni Ottanta si sia verificata una rottura del filo della tradizione del movimento operaio e comunista, anche nel nostro Paese. Questo contribuisce ad allargare il fossato tra ideologia ed esperienza sociale non meno dell’affermarsi di forme nuove di sfruttamento e del declino della grande fabbrica.
8. Perdita del lessico del conflitto.
Assieme alla memoria, il conflitto sociale ha perso anche il suo lessico (a partire dal concetto stesso di “classe”). Il compito di dare un nome alle cose, ossia alle lotte e alle loro ragioni e finalità, si trova oggi a dover ripartire praticamente da zero. La desertificazione concettuale prodotta nel nostro campo dalla reazione neoliberale comporta la necessità di ricominciare, letteralmente, a definire la realtà sociale combattendo e contraddicendo, punto per punto, le categorie dominanti. Per restare nel campo del lessico economico, parole quali “mercato”, “flessibilità”, “efficienza”, “produttività” andranno quindi tradotte in un orizzonte categoriale diverso ed alternativo rispetto a quello oggi dominante (e dominante anche a sinistra). Questo compito non andrà sottovalutato ove si voglia dare spessore, organicità e durevolezza alle lotte, sottraendole alla loro contingenza ed episodicità.
9. Nichilismo storico.
Luciano Canfora di recente ha osservato che, “con la fine dell’URSS, cambiala prospettiva del giudizio storico”: il giudizio che anche molti non comunisti avevano espresso sugli eventi successivi all’ottobre, “grandi e disumani sacrifici, ma forieri di un grande risultato”, diventa ora: “grandi, disumani sacrifici, ma per nulla!” [25]. In questo modo l’esperienza bruciante della fine del “socialismo reale” sovietico sembra dare evidenza empirica alla “fine delle grandi narrazioni” predicata dai teorici del postmodernismo (uno su tutti: J. F. Lyotard). Il punto di approdo per molti diviene così il nichilismo storico: la storia non ha un senso, è un’ininterrotta ed irredimibile sequenza di violenze e atrocità. È facile osservare che questo avviene esattamente nel momento in cui gli ideologi contemporanei della borghesia (che sempre più spesso si manifestano come dei veri e propri “stalinisti del capitalismo”) [26] elaborano le loro “piccole narrazioni” nelle quali la società capitalistica è descritta come il definitivo punto di approdo della storia umana. Se osserviamo i caratteri di quel nichilismo storico, ci accorgiamo dell’atteggiamento completamente liquidatorio che lo caratterizza, sotto almeno tre profili: nelle società nate dall’ottobre sovietico sarebbe stato tutto da buttare (salvo stupirsi di fenomeni di massa quali la “nostalgia del comuniSmo” diffusi nei paesi dell’est europeo) [27]; vengono ignorati i processi di liberazione del Terzo mondo, resi possibili dall’esistenza del “blocco socialista”; e le stesse conquiste sociali ottenute nel dopoguerra in molti paesi capitalistici vengono viste retrospettivamente come benevole concessioni del capitale, rese possibili esclusivamente da un ciclo economico eccezionalmente espansivo [28].
Da dove ripartire?
Come è ovvio, non esistono “punti archimedei” per ribaltare la situazione descritta. Si può però provare ad indicare almeno alcune precondizioni per ripartire.
- Centralità della battaglia delle idee. La battaglia delle idee è oggi un aspetto cruciale dell’impegno per una trasformazione socialista della società. In sua assenza, non ci sono “condizioni oggettive” che tengano: la reazione le utilizzerà a suo favore. È questo il grande insegnamento che ci viene dalle catastrofi reazionarie del XX secolo. Per questo oggi la lotta per un diverso ordine sociale non può trascurare una battaglia, ingaggiata a partire dalle parole e dai concetti, al fine di fronteggiare e combattere l’ideologia dominante.
- Presenza nelle lotte di oggi, in Italia e nel mondo. Presenza nelle lotte significa fare concretamente i conti con la disarticolazione (e nuova articolazione) del mondo del lavoro salariato nei paesi a capitalismo avanzato, ma anche confrontarsi con le esperienze odierne di conflitto a livello internazionale. Da questo punto di vista l’intemazionalismo non è un alibi, né – come a volte si pensa – una fuga rassicurante in un altrove tanto poco conosciuto quanto idoleggiato. L’internazionalismo è invece un importante punto di appoggio sia in termini pratici, sia in quanto ci consente di considerare in termini più generali e dinamici l’evoluzione storica del nostro tempo – dando così più respiro alle nostre stesse battaglie. Il paradigma non potrà più essere quello del “modello” da copiare, ma quello di “strade” di- verse che, con punti di partenza e percorsi differenti, vanno in una stessa direzione.
- Così come la battaglia delle idee non può essere realizzata per così dire sotto una campana di vetro, lontana e distaccata dai conflitti reali, allo stesso modo la prassi deve potere essere innervata di teoria. Riprendere gli strumenti di analisi critica della realtà sociale capitalistica elaborati da Marx e dal marxismo è tuttora una necessità ineludibile.
- In questo contesto rientra anche il confronto critico con la storia e le esperienze del “socialismo realizzato’. Effettuare un esame approfondito di queste esperienze – esame del quale rincontro di questi giorni vuole essere soltanto l’inizio – non significa ricerca di “modelli”, ma confronto con i problemi di fondo sollevati da quelle esperienze: combattendo la damnatio memorine oggi invalsa e affrontando temi quali l’economia di piano ed il superamento della proprietà privata dei mezzi di produzione.
Ma attenzione: anche questo confronto va stabilito a partire dalla consapevolezza che soltanto chi ha un futuro ha anche un passato. Quest’ultimo aspetto è cruciale: per riannodare i fili della tradizione del movimento operaio e comunista è necessario evitare l’atteggiamento nostalgico, da orfani di una storia gloriosa che appartiene ad un passato irrevocabile e perduto. L’impostazione deve essere rovesciata: bisogna far propria la convinzione che soltanto chi costruisce il futuro ha anche un passato a cui riferirsi e da cui trarre insegnamenti. Aveva ragione Walter Benjamin quando osservava che “la storia ha il compito non solo di impossessarsi della tradizione degli oppressi, ma anche di istituirla” [29]. Questo per noi significa: trovare nella tradizione del movimento operaio e comunista del XX secolo, nella nostra storia, quello che ci serve per costruire la storia del movimento comunista del XXI secolo.
E questa storia si costruisce a partire dal presente. Ossia dalla configurazione attuale del lavoro salariato e dalle forme fenomeniche odierne oggi assunte dal conflitto di classe e dai suoi protagonisti. Cosicché, se la precarietà dei lavoro è divenuta un elemento costitutivo dell’attuale divisione del lavoro, grazie all’enorme diffusione di lavoro precario, nero e intermittente come fenomeni non più marginali, ma tipici del mercato del lavoro, allora il nuovo movimento operaio dei nostri giorni non potrà non essere formato dai soggetti del lavoro, del lavoro negato e del non lavoro: ogni progetto di ricomposizione ed organizzazione della soggettività di classe dovrà muovere da questo dato di fondo. Allo stesso modo, dal momento che 1’esistenza di una unità monetaria permette – almeno tendenzialmente – l’omogeneizzazione del processo di valorizzazione del lavoro sociale su scala europea, la nuova soggettività di classe dovrà sapersi sviluppare in un orizzonte non più rinchiuso entro i confini nazionali [30].
Con il cambiare delle forme fenomeniche non muta però l’esigenza di fondo: ricostruire una soggettività che riproponga con forza il tema del cambiamento sociale. Questo nostro incontro intende rappresentare un contributo in questa direzione.
NOTE
[1] ↑ F. Fukuyama, La fine della storia e l’ullimo uomo, tr. it. Milano, Rizzoli, 2002, p. 69. Le citazioni successive sono tratte dalle pp. 69-70, 127, 10, 277,289, 102, 18
[2] ↑ Non è chiaro come entri in questo schema idilliaco la Prima Guerra Mondiale.
[3] ↑ A. Asor Rosa, La guerra. Sulle forme attuali della convivenza umana, Torino, Einaudi, 2002, pp. 48,58,159,180 sg..
[4] ↑ S. Hersch, ‘Le prossime guerre”, tr. it. in Intemazionale, 28/1/2005.
[5] ↑ C. Lellouche, Il nuovo mondo, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 16. Per una notazione ironica sulle teorie di Fukuyama v. p. 52.
[6] ↑ Vedi in particolare: Lo “belle epoque” è finita! Imperialismo ed economia di guerra, Quaderno di Contropiano per la Rete dei Comunisti. Roma, 2001; L. Vasapollo (a cura di), Il piano inclinato del capitale. Crisi, competizione globale e guerre, Milano, Jaca Book, 2003; M. Casadio, 1. Petras, L. Vasapollo, Clash! Scontro tra potenze. La realtà della globalizzazione, Milano, Jaca Book, 2004; Target. Iraq, competizione globale e autodeterminazione, Quaderno di Contropiano per la Rete dei Comunisti, 2004; 1. Arriola, L. Vasapollo, La dolce maschera dell’Europa. Per una critica delle politiche economiche neoliberiste, Milano, Jaca Book, 2004; L. Vasapollo (a cura di), Lavoro contro capitale. Precarietà, sfruttamento, delocalizzazione, Milano, Jaca Book, 2005; J. Arrida, L. Vasapollo. L’uomo precario nel disordine globale, Milano, Jaca Book, 2005; Lavoro contro capitale. Egemonia e politica nell’epoca del conflitto di classe globale. Quaderni di Contropiano per la Rete dei Comunisti, Roma, 2005.
[7] ↑ In proposito vedi i dati riportati in J. Halevy, ‘Stagnazione e crisi: Usa, Asia nippo-americana e Cina”, in L. Vasapollo (a cura di), Lavoro contro capitale. Precarietà, sfruttamento, delocalizzazione, Milano, Jaca Book, 2005, pp. 181 sgg.
[8] ↑ K. Marx, Il capitale, 1. III, cap. 14; tr. it. di M. L. Boggieri, Roma, Editori Riuniti, 1980, p. 283 sgg.
[9] ↑ Sul punto vedi N. Colajanni, Il miracolo americano: un modello per l’Europa?, Milano, Sperling & Kupfer, 2000, p. 30 sgg.
[10] ↑ K. Marx, Il Capitale, I. III, ciL, cap. 14, p. 290. Analoghe considerazioni erano siate espresse nel Manifesto del partito comunista a proposito della creazione del mercato mondiale.
[11] ↑ K. Marx, Il capitale, I. III, ciL, cap. 15, p. 293.
[12] ↑ La migliore antologia disponibile in Italia a questo riguardo resta quella curata da R. Monteleone, Teorie suU’imperialismo, Roma, Editori Riuniti, 1974.
[13] ↑ Per le caratteristiche deH’imperialismo vedi V.I. Lenin, L’imperialismo, fase suprema del capitalismo, 1916; tr.it. in Scritti economici, a cura di U. Cenoni, Roma, 1977, p. 571. Sull’attualità dell’esposizione di Lenin vedi V. Giacché, “Capitale Finanziario e imperialismo. Ieri e oggi”, lEmesto, n. 3/2004
[14] ↑ Questa espressione fu coniata da De Gaulle (N.d.R.).
[15] ↑ James K. Galbraith, “Apocalypse Not Yet”, in TomPaine.com, 6/12/2004: www.tompaine.com/print/apocalypse_not_yet.php (corsivi miei). L’autore è il figlio di John Galbraith, scomparso di recente. Ho esposto con maggiori argomenti quanto segue in A. Burgio, M. Dinucci, V. Giacché, Escalation. Anatomia della guerra infinita, Roma, DeriveApprodi, 2005.
[16] ↑ G. Carli (con P. Peluffo), Cinquant’anni di vita italiana, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 412 sg.
[17] ↑ Sul crescente intervento statale vedi M. Casadio ecc., Clash!, cil, pp. 38-9,60,68,190 e passim.
[18] ↑ Vedi rispettivamente: J. Mueller, Retreat Tram Doomsday. The Obsolescence of Major War, 1989 (cit in S. Lindqvist, Sei morto! Il secolo delle bombe, tr. it. Milano, Ponte alle Grazie, 2001, p. 315) e S. Fidler, ‘Rumsfeld outlines pian for military to tight two conflicts’, in Financial Times, 22/6/2001. Per inciso, è possibile notare che questa impostazione è precedente all’attentato del- le Torri Gemelle.
[19] ↑ John K. Galbraith, Economia della truffa, Milano, Rizzoli, 2004, pp. 18 sgg.
[20] ↑ L’espressione originaria in lingua inglese è più severa: “failures”, ossia “fallimenti”. Ormai anche le nostre traduzioni sono eufemistiche…
[21] ↑ V. Giacché, “Totalitarismo: triste storia di un non-concetto “, la Contraddizione, n. 112, genn.-febb. 2006.
[22] ↑ Lo ha fatto recentemente Lester Thurow in una intervista al Sole 24 Ore.
[23] ↑ B Anonimo (= Susan George), Il Rapporto Lugano. La salvaguardia del capitalismo nel ventunesimo secolo, Trieste, Asterios. 2000, pp. 95 sg.
[24] ↑ Di grande interesse in argomento il libro di Z. Bauman, Memorie di classe. Preistoria e sopravvivenza di un concetto, Torino, Einaudi, 1987, che però fotografa una fase precedente all’attuale, ormai caratterizzata dall’ostracizzazione del concetto stesso di “classe” e alla perdita della relativa “memoria”.
[25] ↑ L. Canfora, L’occhio di Zeus. Disavventure della “Democrazia”, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 98.
[26] ↑ L’appellativo, originariamente adoperato da Sebastiano Timpanaro a proposito dello storico liberale Rosario Romeo, appare oggi appropriato in molti altri casi.
[27] ↑ Nostalgia del comunismo è anche il titolo di una raccolta di studi e testimonianze pubblicata qualche anno fa su questo argomento da Bruno Mondadori.
[28] ↑ Si veda invece la posizione, molto più corretta ed onesta, di Napoleone Colajanni: “nel dopoguerra la socialdemocrazia ha avuto la sua stagione d’oro grazie a due fatti: la partecipazione dell’URSS allo schieramento delle nazioni che combattevano il nazismo ha dato impulso alla domanda di riforma sociale che covava sotto le ceneri in tutti i paesi europei, mentre lo sviluppo del capitalismo creava le risorse perché questa domanda potesse essere soddisfatta… Dopo il 1989 e il crollo del comuniSmo, le cose mutarono” (N. Colajanni, Capitalismi. Asia, Stati Uniti, Europa nell’economia globale, Milano, Sperling & Kupfer, 2006, pp. 1-2).
[29] ↑ M Materiali preparatori delle Tesi sul concetto di storia, in W. Benjamin, Sul concetto di storia, a cura di G. Bonola e M. Ranchetti. Torino, Einaudi, 1997, p. 93.
[30] ↑ J. Arriola, L. Vasapdlo, La dolce maschera dell’Europa. Per una critica delle politiche economiche neoliberiste, Milano, Jaca Book, 2004, p. 153 e p. 117.