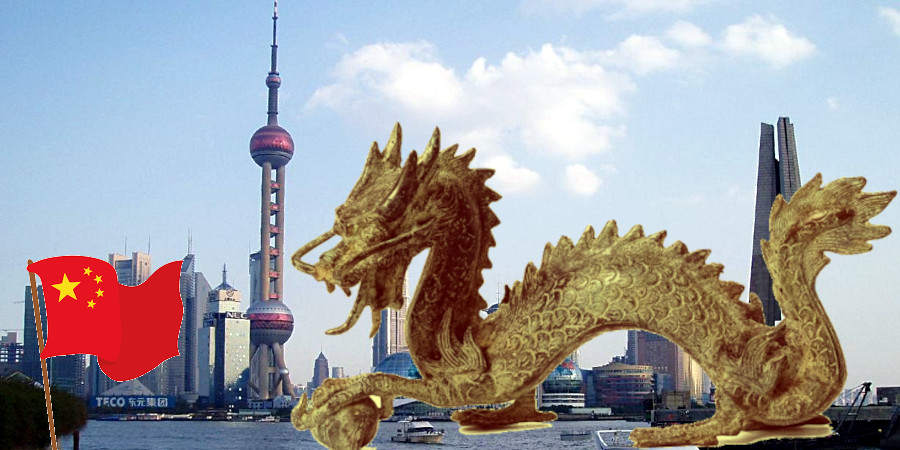Mauro Bulgarelli (Relazione al I° Forum promosso dalla Rete dei Comunisti – Roma 13-14 Maggio 2006)
Penso sia inutile sottolineare che il tema di fondo di questa serie di incontri – un ragionamento organico sul novecento, sull’esperienza storica del movimento comunista e sulle sue prospettive per il XXI secolo- sia particolarmente impegnativo, soprattutto perché esso necessariamente comporta il tornare a fare i conti con concetti come “socialismo”, “classe”, “rottura rivoluzionaria”, “Stato” e “potere” che appartengono alla formazione politica di molti di noi e che oggi, tuttavia, stentiamo a ricollocare nel nostro agire politico. È opportuno chiarire subito che se ciò accade è soprattutto perché gli esiti materiali di queste categorie non sono stati felici: il movimento comunista novecentesco è stato sconfitto, nonostante straordinari cicli di lotte, giganteschi sommovimenti di popolo, imponenti processi di trasformazione sociale. Questo dato di fatto non può essere rimosso ma, d’altra parte, non può certo suonare come uno “sciogliete le righe” per i comunisti del terzo millennio: la capacità del capitalismo di uscire dalla crisi profonda in cui è precipitato nella seconda metà del secolo scorso è coincisa, infatti, con un ulteriore inasprimento dei livelli di sfruttamento di enormi masse di uomini e donne, soprattutto nel cosiddetto terzo mondo e in molti paesi dell’ex blocco sovietico. Detto in estrema sintesi: il capitalismo, nel perpetuare se stesso, perpetua le condizioni e le ragioni per il suo abbattimento, raccolte attorno alla persistenza della contraddizione tra capitale e lavoro che, seppure in forme più complesse, permane il motore delle diseguaglianze anche nelle società contemporanee. Il socialismo si è cimentato su questo terreno aspro di conflitto, ha cercato di invertire la rotta della storia e, nonostante molti di noi abbiano criticato le esperienze materiali cui ha dato luogo, esso fa parte a pieno titolo della nostra genealogia, avendone scandito alcuni passaggi fondamentali: la nascita del ciclo del comuniSmo asiatico governato dai partiti operai prodotti dall’ultima fase della sussunzione formale del lavoro al capitale, la rivolta dell’operaio professionale dell’ottobre sovietico fino all’autunno caldo dell’operaio massa. Il socialismo si distende lungo questo arco temporale, determinando momenti di sintesi delle potenzialità del lavoro vivo liberato e dinamiche di sovrapposizione, irrigidimento e blocco sociale. Per raccogliere al fondo la specificità di questo processo contraddittorio è dunque impossibile prescindere da una considerazione di fondo: il socialismo ha organizzato, che piaccia o no, gli esiti della rottura rivoluzionaria e il rapportarsi della soggettività comunista alla tematica della transizione e del potere. Oggi possiamo dire che forme e percorsi adottati sono stati inadeguati ma proprio perché attorno al nodo gordiano della transizione il socialismo ha consumato la sua parabola, è lì che occorre tornare per provare a leggerne le ragioni della crisi. Il socialismo ha provato a stabilizzare i frutti di una rottura radicale, la liberazione del lavoro dal giogo capitalistico nella prospettiva della costruzione di un altro mondo possibile, fondato sull’equa ripartizione della ricchezza, sulla socializzazione dei mezzi di produzione, delle opportunità e dei diritti. Questa sfida, di per sé immane, è divenuta insostenibile nel momento in cui la presa del potere non si è verificata nell’occidente capitalistico – dunque al punto più alto dello sviluppo- bensì in quelle periferie dove più arcaico e brutale era il rapporto di sfruttamento e più forte e diffusa era la povertà e l’arretratezza economica. Ciò ha comportato un primo pesantissimo handicap, a cui si è cercato di fare fronte intensificando fino all’estremo limite ritmi e tempi di lavoro, varando pianificazioni forzate ed eleggendo il soddisfacimento delle necessità materiali a regola aurea del vivere civile. A ciò si è aggiunto il fatto che la tenuta del capitalismo nelle società avanzate ha determinato la creazione di due campi contrapposti, in aperto conflitto tra loro, la cui competizione a distanza ha tenuto per decenni il pianeta sull’orlo della catastrofe e ha precipitato il campo socialista in un lunghissimo, estenuante assedio. Potremmo dire che la società socialista è sempre stata in guerra, senza riuscire a vincerla. Si può discutere se le radici di questa sconfitta affondino in un retroterra più remoto, nella cristallizzazione burocratica di alcune idee-forza prodotte dalla borghesia francese rivoluzionaria, come l’egualitarismo, la giustizia, lo sviluppo. Di certo il socialismo reale è stato costretto ad assumere un assetto pragmatico come termine di mediazione tra la radicalità utopica dell’organizzazione sociale comunista e la materialità storica, fatta, appunto, di arretratezza e accerchiamento, tanto che la metafora del muro, oltre ad aver contrassegnato a lungo la separazione tra Oriente e Occidente, può anche efficacemente simboleggiare la frattura tra questa dizione utopica e la sua impossibile approssimazione in fieri. A questa penalizzante condizione di partenza si sono aggiunte politiche segnate da drammatici errori di prospettiva, il più grave dei quali è risieduto probabilmente nella scelta della competizione economica con il capitalismo attraverso l’estrazione pianificata di plusvalore. Marx, con la consueta capacità di anticipazione, avvertì il pericolo di una simile involuzione coniando la definizione “socialismo da caserma”, quanto mai appropriata per descrivere la ferrea militarizzazione della produzione che con costi umani altissimi portò al capitalismo di stato. Questa scelta di potenza, come è noto, ebbe come esito esterno una politica estera aggressiva, che contribuì alla generale corsa al riarmo del pianeta, all’ipertrofia degli apparati militari, alla escalation nucleare. All’interno, la convinzione che la costruzione della società socialista dovesse essere incardinata su uno sviluppo meccanicistico e brutale delle forze produttive determinò una sottovalutazione fatale della soggettività sociale, clamorosi fraintendimenti sulla sua composizione politica, sulla sua interna mobilità e capacità di ricombinazione. Dispositivi di regolazione gerarchica delle relazioni intersoggettive si attivarono nel tentativo di governare, di irretire questo interno ribollire della composizione di classe, finendo soltanto per accelerare il punto di rottura del sistema.
La concomitanza di questi piani di crisi si tradusse infine nello sviluppo di dinamiche autodistruttive che minarono alle fondamenta il sistema socialista ben prima che la caduta del muro ne formalizzasse la fine. Il ‘900, dunque, si chiude con il crollo – meglio, con l’implosione- di questa gigantesca costruzione prometeica ma la sua fine, che anche simbolicamente chiudeva un’epoca, ci lascia un’eredità inattesa, per molti versi spiazzante. A quindici anni di distanza possiamo constatare che:
- la fine del sistema socialista ha significato, per le centinaia di milioni di uomini e donne che ne facevano parte, un brutale passo indietro in termini di diritti e, soprattutto, di benessere materiale. Quest’ultima considerazione può suonare come paradossale, visto che il socialismo è stato sempre costretto a fare i conti con la dimensione della scarsità e non è riuscito ad andare oltre una ridistribuzione egualitaria delle risorse disponibili, ma è un dato di fatto che le condizioni di vita delle popolazioni dell’ex campo socialista si presentano oggi drasticamente peggiorate, all’insegna di disuguaglianze feroci e sfruttamento selvaggio della forza lavoro. Il confronto con il mercato globale ha indotto conseguenze drammatiche per i paesi dell’Est, verso i quali le potenze capitalistiche della nuova Europa hanno sperimentato le politiche di rapina applicate nei confronti dei paesi del terzo mondo: da una parte si è promossa una liberalizzazione economica senza freni, dall’altra si è impedita la creazione di un mercato interno, in modo da usufruire della manodopera a basso prezzo che lo scardinamento dello Stato sociale ha prodotto a Est. Della privatizzazione dello Stato burocratico e della demolizione del welfare hanno approfittato mafie, ex apparati e multinazionali, mentre a sopportare i costi drammatici di questa nuova accumulazione originaria, fatta di espropriazione e violenza, è rimasta una classe operaia senza tutele e prospettive di emancipazione. Va detto senza mezzi termini che l’accelerazione impressa alla costituzione dell’Europa di Maastricht, di Schengen e della Bolkestein sarebbe stata impensabile senza lo sgretolamento dei paesi socialisti.
- Il crollo del muro non ha liberato energie creative, non ha rimesso in moto un movimento sociale di critica radicale ma ha dato luogo a micronazionalismi, arroccamenti identitari, conflitti etnici, abilmente incentivati ed eterodiretti per agevolare il controllo capitalistico su aree strategiche per il mercato globale. Al dirigismo burocratico, al dominio del capitale collettivo sulla cooperazione sociale produttiva – che aveva funto da regolatore sociale nel sistema socialista – non è seguita una mobilitazione dal basso del lavoro vivo, non si sono date nuove opportunità di protagonismo sociale, di autogestione e di ridistribuzione della ricchezza; al contrario, nell’Est post-socialista si è determinata una vera e propria decomposizione dello spazio pubblico, frantumatosi sotto l’azione di particolarismi, egoismi, competizione individualistica, pulsioni autodistruttive. Questo esito infausto, sollecita un confronto ragionato tra la concezione federalista che da Lenin in poi ha caratterizzato la costruzione delle società socialiste e quella sponsorizzata, ad esempio, dalle potenze capitalistiche occidentali per il dopo-Jugoslavia. Della prima conosciamo i limiti derivanti dall’essere stata sussunta in un’architettura verticistica facente capo alla burocrazia sovietica; della seconda possiamo solo constatare che in luogo di una coesistenza talvolta problematica tra comunità diverse essa ha edificato uno spazio militarizzato entro il quale quelle stesse comunità sono divenute protettorati dell’impero, senza alcuna prospettiva reale di autodeterminazione e di sviluppo.
- Un’ultima considerazione riguarda una concomitanza che certamente non è solo temporale: il sistema socialista si inabissa dopo che nell’occidente avanzato – per tutti gli anni settanta- le lotte operaie, i movimenti sociali e le avanguardie comuniste sviluppano un’offensiva che è sul punto di mettere in ginocchio il sistema capitalistico, scosso nelle fondamenta prima dalla crisi del fordismo e poi dalla crisi fiscale del welfare state e delle politiche di regolazione keynesiane. A essere messo in discussione non è soltanto il modo di produzione capitalistico ma lo stesso impianto istituzionale – a partire dalla forma Stato -, il sistema di valori, i luoghi e i processi di riproduzione del sapere e della cultura. La radicalità di queste lotte prospetta per la prima volta la possibilità di una rottura nel punto più alto dello sviluppo mentre nelle periferie del mondo movimenti di liberazione incrinano profondamente le strategie di comando imperialiste. Ma il capitalismo riuscirà ad assorbire questa formidabile onda d’urto e a recuperare, negli anni ottanta, progettualità e capacità di governo del sistema produttivo. Contemporaneamente, il blocco socialista, come dicevamo, entra nella fase di crisi più profonda, quella che nel giro di qualche anno porterà alla sua dissoluzione. A questo proposito occorrerebbe iniziare a riflettere, nei contesto di un più generale ripensamento sugli anni settanta, su questa contemporaneità, se cioè tra la sconfitta del movimento anticapitalista e la crisi del socialismo vi sia un qualche nesso di causalità, se l’una abbia accelerato l’altra o se le due parabole siano giunte a compimento su versanti indipendenti. Non si tratterebbe di un puro esercizio di stile, perché nonostante i movimenti sociali degli anni settanta abbiano preso le distanze in modo molto netto dall’esperienza del socialismo reale, criticandone in particolare le limitazioni alla sfera delle libertà e la svolta militarista impressa in politica estera, è indubbio che 1’esistenza di un campo socialista abbia svolto un ruolo di primo piano e un punto di riferimento – quantomeno “logistico”- per molte lotte di liberazione che hanno assunto un particolare valore simbolico nell’immaginario collettivo antagonista degli anni settanta, dal Sud Est asiatico al Medio Oriente, senza parlare della grande attrattiva esercitata dalla Cina di Mao.
La riflessione su questi temi, in particolare sull’esperienza storica del socialismo novecentesco, non è inoltre una questione accademica anche in riferimento all’oggi. Il XXI secolo ha portato infatti alla luce un nuovo soggetto sociale, nato nelle strade di Seattle e caratterizzato da una eccezionale mobilità e capacità di contaminazione. Questo soggetto, generato dalla contestazione alla globalizzazione capitalistica, ha espresso, nuovamente, una domanda radicale di trasformazione, condensata nella rivendicazione di “un altro mondo possibile”, e si è fatto portavoce di una visione della società fondata sulla condivisione dei beni comuni, sulla gestione dal basso della cosa pubblica, sulla riappropriazione dei nessi amministrativi, sulla cooperazione sociale e l’opposizione intransigente alle politiche belliche del neoimperialismo americano. Una delle sue caratteristiche peculiari si è rivelata la capacità, da Porte Alegre in poi, di darsi processualmente delle sedi di dibattito e di sperimentazione materiale di queste politiche autogestionarie e di relazionarsi con quei movimenti nati nel Sud del mondo, in particolar modo in America Latina, che subivano in prima persona il peso della globalizzazione neoliberista e si scontravano con le strategie multinazionali di espropriazione e privatizzazione delle risorse naturali. Le lotte in difesa dell’acqua, in quanto bene comune inalienabile, sono esemplificative della convergenza determinatasi tra questi diversi soggetti mentre il municipalismo ha rappresentato, sebbene in misura molto parziale, il tentativo di tradurre operativamente e dare stabilità a questa nuova visione del mondo. A distanza di qualche anno, dobbiamo constatare, però, che il movimento antiglobalizzazione è entrato in una fase di stallo: la capacità di attrazione si è progressivamente ridimensionata, così come quella di sperimentazione sul campo, e, più in generale, è venuta meno la forza di anticipazione politica. Detto in due parole, si è determinata una crisi di prospettiva strategica.
Negli stessi anni, nel Sud del mondo, quei movimenti con i quali il popolo di Porto Alegre si era relazionato sono divenuti parte integrante di un impetuoso cambiamento sociale che ha trovato clamorosi riscontri anche in sede istituzionale: dall’Argentina, alla Bolivia, al Venezuela, al Brasile, al Cile, l’America latina non è più il cortile di casa degli Usa né il laboratorio di organizzazioni come la Banca mondiale o il Fondo monetario internazionale. Le forme di governo scaturite nell’ambito di questo processo sono per molti versi inedite e raccolgono, rielaborandole, eredità politiche di vario tipo, dal bolivarismo, alla teologia della liberazione, alla “democrazia rivoluzionaria” chaveziana fino al più classico socialismo populista. Questo ricambio istituzionale non nasce da rotture rivoluzionarie ma è fuor di dubbio che costituisce il prodotto anche delle lotte condotte nei decenni passati dai movimenti rivoluzionari nonché la risposta – sicuramente ancora insufficiente- alla contraddizione capitale/lavoro che la globalizzazione neoliberista ha concentrato in questa parte del mondo in forme particolarmente feroci. Potrebbe essere stimolante, discutendo dell’attualità o meno del socialismo, chiedersi se queste due diverse forme di resistenza alla globalizzazione capitalistica possano vicendevolmente giovarsi di frequentazioni più assidue, di un confronto sulla materialità delle reciproche sperimentazioni, sviluppando una prospettiva più matura e complessa di trasformazione sociale. In fondo, l’universo di forze gravitanti attorno ai forum sociali non è riuscito, al di là della giustezza di molte analisi, a “dare un nome” all’altro mondo possibile, a prefigurare uno scenario realistico per la sua attuazione, mentre, d’altra parte, sarebbe sicuramente un grave errore se le varie esperienze neosocialiste ricadessero nella tentazione della scorciatoia statalistico-burocratica che, come abbiamo visto, è stata una delle principali responsabili della crisi del socialismo novecentesco.
Detto questo, sarebbe comunque un errore di metodo chiedersi, in astratto, se il socialismo sia ancora oggi praticabile. Più opportuno sarebbe domandarsi se la contraddizione cui esso ha cercato di dare una risposta, quella tra capitale e lavoro, sia tuttora vigente e in che forme. Se ragioniamo attorno a questo nodo, potremmo avere la possibilità di abbozzare un bilancio del novecento e, forse, maggiore chiarezza circa le sfide che ci riserva il nuovo secolo.
Marx scriveva, nei Grundrisse, che “Il vero non-capitale è il lavoro”; il capitale, in altri termini, esercita il suo potere sul lavoro, sfruttandone la forza creatrice e realizzando valore e ciò pone i due soggetti della relazione in un antagonismo assoluto, li rende l’uno la negazione dell’altro. La legge del valore si configura come legge del plusvalore, cioè dello sfruttamento, proprio a partire dalla non mediabilità di questo conflitto primario. Oggi, tuttavia, la contraddizione capitale/lavoro si è arricchita di nuove implicazioni sociali. Il valore, giunti a questo stadio dello sviluppo, non definisce più, semplicemente, la misura del lavoro – come prevedeva la teoria economica classica, che per il computo si serviva delle unità di tempo lavorato- bensì si riferisce alla complessità del sistema di produzione-distribuzione-riproduzione, all’intero asse che raccorda il processo lavorativo al consumo finale delle merci. Ora, il fatto che la legge del valore non sia riducibile a definizione della misura, non mette affatto in discussione la vigenza della contraddizione tra lavoro e capitale, ponendo invece il problema di ridefinire il lavoro e, di conseguenza, il tipo di sfruttamento che attraverso di esso si attua. Detto in due parole, il processo di valorizzazione si realizza ai giorni nostri mediante la socializzazione del lavoro e dunque il concetto di sfruttamento non è più riconducibile, semplicemente, alla quantità del valore estorto, essendo esso difficilmente quantificabile, ma alla circolarità della produzione sociale. La globalizzazione dei mercati ha impresso una spinta formidabile a questo dinamica e l’importanza assunta dalla comunicazione e dal lavoro intellettuale ha ulteriormente approfondito questo passaggio. Lo sfruttamento rimane dunque, in prima istanza, espropriazione del prodotto del lavoro sociale: solo che questa densissima determinazione economica non è che l’anima interna della funzione politica. Cosa vuol dire? Che Io sfruttamento è politicamente prodotto come funzione di potere da cui discende una gerarchia sociale, cioè un sistema di matrici e di limiti adeguati alla riproduzione del sistema. La società è stata messa in valore, definitivamente e completamente. Lavoro, non lavoro, produzione e riproduzione, circolazione e distribuzione, non sono più concepibili come fasi del ciclo accumulativo ma come continuum della valorizzazione sociale; esse non esercitano soltanto una funzione propedeutica l’una rispetto all’altra, ma si fondano reciprocamente nel fluire ininterrotto del processo di accumulazione. Questa fluidità e pervasività del valore, pertanto, non può essere irreggimentata nel modo di produzione, poiché il fulcro della valorizzazione non è soltanto la capacità lavorativa dei soggetti, la forza-lavoro, né, tanto meno, l’oggetto di questa attività del produrre, la merce, quanto piuttosto, la forza creatrice, il lavoro vivo, il soggetto stesso. L’intera gamma dei rapporti sociali (qui intesi nell’accezione più larga di relazioni intersoggettive) soggiace a questa regola; la creatività, si definisca come lavoro astratto o agire comunicativo, viene progressivamente sussunta nel ciclo di riproduzione di capitale. Essa viene usata, in quanto generai intellect, nell’ambito della cooperazione sociale produttiva; viene accumulata, rigidificata da quei limiti funzionali alla riproduzione del sistema e, sotto forma di soggettività nomata, inserita nella costituzione capitalistica del sociale. Questo capitale che si costituisce come mondo reale, questa società che non è più calco ma clone del capitale si affermano come condizioni irrinunciabili per la sopravvivenza del sistema.
Quanto fin qui detto, tuttavia, rappresenta soltanto un lato della medaglia, nel senso che le modificazioni intervenute nei meccanismi di estrazione di plusvalore non comportano la scomparsa della contraddizione “classica” tra capitale e lavoro che, come abbiamo visto, si è localizzata nelle aree del pianeta economicamente più arretrate, dove vere e proprie zone di produzione servile permettono al capitale multinazionale uno sfruttamento della forza lavoro ad altissima intensità. Qui il lavoro rimane dequalificato, scandito dai tempi della catena di produzione e di natura preminentemente manuale, nonostante nella maggior parte dei casi le merci prodotte siano a elevato tasso tecnologico e destinate a essere utilizzate in attività lavorative immateriali (un esempio per tutti è quello della componentistica hardware). E non è azzardato affermare che la proliferazione del lavoro immateriale è legata in buona misura alla persistenza di queste forme “novecentesche” di produzione. Non solo: le esigenze della globalizzazione hanno fatto sì che tali forme non siano soltanto localizzate e stanziali ma estremamente mobili e capaci di riprodursi nel cuore dello sviluppo. Basti pensare alla funzione assolta dai flussi migratori, che deterritorializzano le forme classiche di estrazione di plusvalore, le insediano, a seconda delle esigenze, nel tessuto sociale delle società avanzate, per poi smantellarle e ricollocarle altrove. La nuova economia mondiale è dunque un ordine complesso, sovrapposto e disgiuntivo, non più comprimibile nel modello centro-periferia, caratterizzato da una configurazione globale fluida all’interno della quale le sorti dell’industria multinazionale sono determinate in misura sempre più marcata dall’interrelazione tra flussi monetari, distribuzione ineguale della tecnologia, disponibilità sia di forza lavoro altamente specializzata che totalmente dequalificata. La legge del valore si alimenta oggi del turbinio di questa gigantesca macchina.
A marcare, infine, uno scarto netto, per quanto riguarda le dinamiche di estrazione di plusvalore, tra il secolo passato e quello attuale è la comparsa di una variante inedita, costituita dall’ambiente. Henry Ford, in una dichiarazione al “Chicago Tribune” del 1916, affermava: “La storia è pressoché una bubbola. Noi non vogliamo la tradizione. Vogliamo vivere nel presente e la sola storia che valga qualcosa è quella che creiamo oggi”. Nella società fordista dei produttori il futuro era considerato alla stregua di tutti gli altri prodotti, era la creazione del lavoro e nello sviluppo si riponeva una fiducia cieca. L’infatuazione moderna per l’idea di progresso, come è noto, era figlia della rivoluzione industriale e dell’ideologia positivista e gran parte del novecento trascorse all’insegna della mobilitazione generale delle forze produttive e dell’obiettivo della piena occupazione, nella convinzione dell’illimitatezza dello sviluppo e delle risorse naturali. La stessa contraddizione capitale/lavoro raggiunse il massimo dell’intensità all’interno del ciclo lotte/sviluppo. Poi, negli anni settanta, la prima crisi energetica e la gravità raggiunta dall’inquinamento ambientale disvelarono impietosamente quanto il mito dello sviluppo infinito fosse illusorio e determinarono una serie di mutamenti di rotta: inizialmente nel mirino della crescita illimitata finì la capacità di assorbimento e di riproducibilità dell’ambiente, destinato da una parte a ricevere scorie, rifiuti ed emissioni di ogni genere e, dall’altra, a essere sottoposto a un ulteriore intensificazione dello sfruttamento delle risorse. Poi, presa definitivamente coscienza dei limiti dello sviluppo e della fine prossima della società della piena occupazione, si è puntato sull’introduzione della tecnologia nei processi produttivi e sulla flessibilità del lavoro come strategie per la riproduzione del sistema. L’ultimo passaggio è quello dei nostri anni, con la messa in valore delle residue risorse naturali disponibili e il varo di strategie finalizzate alla loro privatizzazione. Le società socialiste hanno fatto la loro parte in questa corsa folle che ha attraversato il novecento, imprimendo un’accelerazione inaudita alla produzione e determinando danni altrettanto inauditi all’ambiente. E oggi, a testimoniare della dissennatezza di quella corsa, rimane lo spettacolo spettrale di quel che resta del lago d’Aral: 60 km di superficie desertificata sotto la quale affiora ogni sorta di rifiuto tossico, nessuna forma di vita animale o vegetale, nubi velenose che senza sosta il vento trasporta fin sulla vetta dell’Himalaya.
Sono proprio la fine dello sviluppo e le conseguenze catastrofiche da esso generate a dirci che il novecento è definitivamente, inappellabilmente concluso. Del tutto aperte sono invece le questioni che il XX secolo ha posto, la prima delle quali riguarda la natura del mondo capitalistico che, oggi come allora, ci consegna uno scenario di sfruttamento, povertà, disuguaglianze, sofferenze per enormi masse di esseri umani, che oggi come allora ci fa convivere con guerre e distruzione e ci ripropone il dilemma del “Che fare”? Dopo il crollo del Muro in molti, dai nouveaux philosophes ai teorici del pensiero debole, dai tecnocrati alla nuova leva del riformismo socialdemocratico, si sono affrettati a sentenziare che la storia era finita, che non ci sarebbe stato più spazio per utopie e ribellioni e che si trattava solo di attendere che la vittoria su scala planetaria della “democrazia” (quella americana) dispensasse pace e benessere per tutti. Sono bastati pochi anni per fare giustizia di queste sciocchezze interessate: questo sistema, esattamente come quello novecentesco, merita di essere “rivoluzionato”, essendo fondato su un’architettura di comando irriformabile e per l’essere portatore, oggi più di ieri, di una devastante carica autodistruttiva. La complessità degli scenari contemporanei non può essere dunque un alibi per giocare al ribasso ma uno stimolo per riaffrontare e ripensare forme e modi dell’agire politico e per sperimentare nuovi percorsi di trasformazione sociale. I movimenti novecenteschi, di fronte a questo stesso dilemma, hanno scelto la strada dell’assalto al cielo, della rottura rivoluzionaria e della presa del potere. Oggi abbiamo bisogno di una politica che in forme nuove e con strumenti diversi recuperi quella stessa radicalità, interrogandoci sulla complessità delle forme sociali e sulla natura contraddittoria delle mutazioni dei potere che in quanto tali, tuttavia, contengono sempre la possibilità di un evoluzione di senso opposto, che conduca sul versante della liberazione. È questa possibilità che dobbiamo cogliere per riaprire la partita.